Amarcord
|  |  |  |  |  |  |
| Regia: | Fellini Federico |
|
| Cast e credits: | 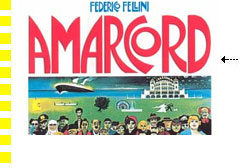
Soggetto e sceneggiatura: Federico Fellini, Tonino Guerra, da un'idea di Federico Fellini; fotografia: Giuseppe Rotunno; musica: Nino Rota, Carlo Savina; montaggio: Ruggero Mastroianni; scenografia e costumi: Danilo Donati; interpreti: Bruno Zanin (Titta Biondi), Pupella Maggio (Miranda la madre di Titta), Armando Brancia (Aurelio il padre di Titta), Stefano Proietti (Oliva il fratello di Titta), Giuseppe Lanigro (il nonno di Titta), Nandino Orfei (il "pataca" zio di Titta), Ciccio Ingrassia (Teo lo zio matto), Carla Mora (Gina la cameriera), Magali Noël (la Gradisca), Luigi Rossi (l'avvocato), Maria Antonella Beluzzi (la tabaccaia), Josiane Tanzilli (la "Volpina"), Domenico Pertica (il cieco di Cantarel), Antonino Faà di Bruno (il Conte di Lovignano), Carmela Eusepi (la figlia il Conte di Lovignano), Gennaro Ombra (Biscein), Gianfilippo Carcano (Don Balosa), Francesco Maselli (Bongioanni il professore di scienze), Dina Adorni (signorina De Leonardis la professoressa di matematica), Francesco Vona (Candela), Bruno Lenzi (Gigliozzi), Lino Patruno (Bobo), Armando Villella (Fighetta il professore di greco), Francesco Magno (il preside Zeus), Gianfranco Marrocco (il ragazzo Conte Portavo), Fausto Signoretti (il vetturino Madonna), Donatella Gambini (Aldina Cordini), Fides Stagni (la professoressa di belle arti), Fredo Pistoni (Colonia), Marcello Di Falco (il Principe), Bruno Scagnetti (Ovo), Alvaro Vitali (Naso), Ferdinando De Felice (Cicco); produzione: Franco Cristaldi per F.C. Produzioni (Roma), Pecf (Parigi); distribuzione: Cineteca Nazionale; origine: Francia-Italia, 1974; durata: 127’. |
|
| Trama: | A Borgo, tra il 1930 e il 1935, l'adolescente Titta cresce subendo condizionamenti dentro e fuori dell'ambito domestico; mentre tenta di affermare la propria personalità, gli sovvengono molteplici ricordi. Suo padre Aurelio è un piccolo impresario edile perennemente in discordia con la moglie Miranda; zio Pataca vegeta alle spalle dei parenti; zio Teo è ricoverato in manicomio; il nonno si gode egoisticamente una salute di ferro, non trascurando di prendersi delle libertà con la domestica. Nella provinciale cittadina emergono: Gradisca, una procace parrucchiera; Volpina una ragazza un po' scema e priva di freni inibitori; una tabaccaia mastodontica, quasi mostruosa; un avvocato dalla retorica facile e magniloquente; Giudizio, il matto; Biscein il bugiardo; il motociclista esibizionista e tutta una galleria di personaggi che, agendo nel mondo della scuola, della chiesa, e nelle feste fasciste, nelle celebrazioni folcloristiche o negli avvenimenti eccezionali, rivelano caratteristiche bislacche. Le stagioni trascorrono inesorabili, scandite dal cadere della neve o delle "manine" staccatesi dai primi fiori primaverili. |
|
| Critica (1): | (...) Se si può dire che in genere il cinema di Fellini nasca essenzialmente dal recupero che l'autore fa del proprio passato, tutto questo sembra ancor più vero per Amarcord, nel quale lo stesso titolo indica la dimensione, appunto, del ricordo. La memoria poetica non è il semplice riaffiorare del tempo trascorso. Ciò che la distingue dalla riesumazione dei fatti è la capacità di infrangere la distinzione delle forme temporali. Nel presente il passato è rivissuto ed è capace di incidere su di esso dandogli valore. Contemporaneamente lo stesso valore del passato viene dal presente, dall'attimo nel quale è rievocato. Il tempo dell'orologio, quello che conosce una sola direzione e nel quale il presente è solo un confine effimero ed inafferrabile che segna il continuo precipitare di ciò che non è ancora in ciò che è già stato, è privo di significati umani. Il tempo della coscienza crea questi significati proprio perché è capace di interrompere questo divenire indistinto e di intraprendere un cammino in senso contrario, per ripensare e valutare. (...)
La memoria poetica di Fellini non fa eccezione: la compresenza di presente e passato in lui è continuamente dominata da un diffuso (anche se difficilmente diventa tragico) senso di colpa. Si potrebbe forse dire che in lui il passato incatena il presente, in quanto a questo sembra incessantemente rimproverare qualche cosa. Questa cattiva coscienza è l'espressione di un'esperienza personale e particolare, situabile con molta precisione in un certo spazio e in un certo tempo, e del resto Fellini non ha mai preteso con i suoi film di giungere al fondo di una qualche natura dell'uomo. Tuttavia io credo che la sua sia pur sempre emblematica di una più vasta esperienza, quella che è stata ed è peculiare della piccola e medio-piccola borghesia provinciale e cattolica. L'incapacità di prescindere da un passato castrante esprime il torpore intellettuale e la repressione sessuale e culturale di tutta una struttura sociale. Fellini ha in più, rispetto a tutto ciò, la capacità di rendersi conto del fatto che torpore e repressione sono inaccettabili: non ha certo quella di superarli completamente.
Nei suoi film il ricordo (che sia il suo o quello dei suoi personaggi non ha molta importanza) è sempre qualificato come contrasto tra un presente disordinato e vagamente immorale ed un passato nel quale si colloca l'ordine e la moralità. Tutto questo ha un suo preciso significato storico e sociale: resta vero però che a Fellini interessa unicamente nella sua dimensione individuale e psicologica. Moraldo sente che la propria vita da vitellone contrasta con il modello piccolo-borghese, pulito e tranquillo nella sua mediocrità, che gli è stato proposto attraverso l'educazione. II proprio presente di Vitellone lo angoscia proprio sulla base del suo passato e di quell'esigenza moralistica che questo gli ha instillato. Tuttavia sente l'angustia di questo moralismo e del mondo che gli sta dietro: dal conflitto che così nasce cerca di fuggire andandosene a Roma. Questa fuga non è una soluzione: nella grande città inevitabilmente porta con sé il suo problema, che ne fa un decadente alla ricerca di una mitica redenzione. Ed infatti lo ritroviamo puntualmente, sotto nomi diversi, in tutti i film che seguono I Vitelloni. (...)
Anche del fascismo in una certa misura Fellini fa una maschera. Questa affermazione deve essere intesa nel suo giusto significato: non si intende dire cioè che Fellini voglia minimizzare la realtà tragica del fascismo. Piuttosto egli coglie di quel periodo e di quella mentalità le manifestazioni più epidermiche e più superficiali; quelle appunto che, piaccia o no, erano le più diffuse e le più conosciute nella provincia di un fenomeno che (dal punto di vista della cultura) fu sempre e solo provinciale. Ciò che ne risulta è l'immagine di un mondo retorico e straccione, pieno di entusiasmi di poco conto, se a scatenarli potevano bastare delle insignificanti e ridicole prodezze podistiche. Si può essere tentati di rimproverare a Fellini di non aver preso decisamente posizione contro quel mondo. Prima di tutto, però, riesce difficile pensare che lo dovesse fare proprio lui, il meno adatto, quando in Italia un cinema seriamente antifascista è quasi inesistente. Inoltre non si può non ricordare che a Fellini il fascismo interessa quasi esclusivamente per ragioni cronologiche: esso ha occupato tutta la giovinezza sua e di tanti altri italiani. Quando questi italiani sono piccolo-borghesi, per loro può essere più importante, appunto, ricordare la giovinezza piuttosto che il valore politico del periodo. Quella specie di bonarietà, venata di un vago senso di rammarico per un tempo ormai perduto, deve perciò essere riferita solamente alla giovinezza che con quel tempo se ne è andata. Per il resto ciò che rimane è solo una efficacissima descrizione di un imbecillimento collettivo. Ed ancora, è inesatto dire che un giudizio drastico e radicale non venga dato: piuttosto è solo accennato, anche se per la verità molto decisamente, al di fuori di ogni facile retorica. A parte la beffa dell'internazionale, alla quale i fascisti rispondono al di là di ogni senso della misura, dimostrando la propria impotenza di fronte alla affermazione della dignità e della libertà, resta la sequenza degli interrogatori e dell'olio di ricino. Una materia che si prestava facilmente ad essere trattata o con il piglio stupidamente farsesco cui ci ha abituato un certo tipo di cinema nostrano o con una retorica altrettanto roboante che inutile e vuota, nelle mani di Fellini (del miglior Fellini) è diventata un lucidissimo esempio di cinema antifascista. Pur rimanendo la sua critica agli aspetti secondari dei fenomeno, dalle immagini appare in tutta la sua tragedia il disegno di un mondo che accompagnava al trionfalismo gretto e straccione, che sfruttava ad arte un provincialismo deformato, una crudeltà ed una vigliaccheria pari solamente al livore meschino con il quale trattava i suoi nemici. Con la grettezza dei suoi aguzzini contrasta la dignità e l'umanità di Amedeo, così come quella della moglie e del figlio, che cercano di attenuare le conseguenze psicologiche del sopruso, facendo prevalere nei limiti del possibile il senso del quotidiano vivere assieme. L'aspetto politico di Amarcord non si limita a questo. Quando Amedeo si sente dire da un suo operaio che dopo tanti anni passati a far mattoni lui non ha una casa, questo anarchico che ha messo qualche bene al sole sembra cercare una risposta convincente. In realtà dal suo atteggiamento e dalle sue esitazioni, più che da quello che dice, appare chiaro che la risposta non convince nemmeno lui. Quel che resta certo è l'assurdità di una vita passata a fabbricare mattoni che servono solo per le case degli altri. Questo è ovviamente troppo poco se confrontato con il problema toccato: ma, lo si ripete ancora una volta, è assurdo pretendere da un piccolo-borghese (anche se grande-artista) ciò che invece si dovrebbe pretendere da altri che, pur facendo la voce grossa, spesso non dicono di più di quello che traspare dal discorso di Amedeo.
Si potrebbe poi ricordare la sequenza dello zio matto. In essa si sommano l'interesse direttamente umano e quello indirettamente politico. Alla tragedia di un uomo che può essere se stesso solo in cima a un albero, dal quale gridare al mondo il suo desiderio, si accompagna l'amara considerazione sul significato sociale della malattia mentale. I pensieri più personali e profondi, il candore più indifeso (pensieri e candore resi stupendamente dal bravissimo Ingrassia) sono distorti dai cosiddetti « normali » e, essendo « diversi », sono subito considerati sintomi di malattia. Il malato di mente, come il proletario incarcerato, è la vittima della repressione.
E la violenza della repressione appunto ri-cattura lo zio matto, attraverso la suora nana, figura emblematica che assieme ai due enormi infermieri sta ad indicare che dietro alla follia si collocano forze e mentalità ben precise.
Sulla barca aspettando il Duce con la grande nave, Amedeo si improvvisa filosofo e fa considerazioni sull'universo. Queste sono quasi l'esatto contrario di quelle che il Matto faceva a Gelsomina in La strada. In quel film si diceva che nell'immensità anche un sassolino (quindi anche Gelsomina) ha il suo posto. (Può forse essere interessante ricordare, al di fuori del campo cinematografico, che di fatto, come scrive lo psichiatra Laing, queste parole sono state l'occasione della guarigione di una schizofrenica). In questo invece si parla dell'immensità del cielo, fatta di enormi blocchi di terra o di fuoco che arde da millenni mentre «noi invece siamo dei fiammiferi ». La differenza sta tutta qui: ciò che compare in primo piano, sostituendosi all'ottimismo venato di reminiscenze cattoliche del Matto, è la morte, è la fine dell'individuo che non trova nessuna
contropartita consolatrice. L'individuo è un fiammifero che spesso si sopravvaluta perché non riesce ad avere il senso delle proporzioni.
La morte era già comparsa nell'opera di Fellini, ora vagamente (la vecchiaia di Conocchia in Otto e mezzo sembrava alludervi, ad esempio) ora invece da protagonista indiscussa, come nell'episodio di Tre passi nel Delirio, Toby Dammit, oppure ancora come una dei protagonisti (Satiricon).
Quel che cambia in Amarcord è il significato della morte o, se si preferisce, l'atteggiamento di fronte ad essa. Alla paura angosciosa o alla tragedia si sostituisce una sorta di rassegnata quanto distaccata consapevolezza. Le cose più crudamente accusatrici, quelle che più radicalmente mettono in rilievo l'ingiustizia di un destino che per ognuno si conclude con il nulla, le dice un vecchietto spaurito e indifeso. Anzi le sue parole sono tanto più efficaci quanto più assumono una veste dimessa e quotidiana e quanto meno quindi assomigliano a vuote astrazioni intellettualistiche. Avvolto nella nebbia, nella quale la realtà sfuma nel nulla, il nonno di Titta dice che « se la morte è così non è un bel lavoro... ». In altri termini, che però sono adeguati a questi, chi ha predisposto le cose in questo modo non è un galantuomo: lui, il vecchio, dal canto suo, se si fosse trovato nei suoi panni avrebbe agito diversamente. Il nipote più giovane che con baldanza, quasi stupito delle esitazioni e dello smarrimento del nonno, se ne va nella nebbia è forte della sua giovinezza. È un fiammifero che ha appena cominciato a ardere. Ma il cammino non è poi così tranquillo come la sua sicurezza lasciava credere: lungo la strada si colloca l'imprevisto, la sagoma del bue velata e ingigantita dalla nebbia. Il fantastico non è solo la dimensione della speranza, ma anche quella delle paure e delle angosce che accompagnano l'uomo nella sua vita. Attraverso queste paure e queste angosce il ragazzo sta andando, senza saperlo, là dove il nonno è già quasi giunto. Al matrimonio di Gradisca manca la nota caratteristica di queste occasioni: la gioia ha lasciato il posto ad una sorta di diffusa malinconia. Questa, è ovvio, è molto più di Fellini che della sposa. Gradisca sognava un avvenire che la sottraesse al grigiore del suo mondo, invece si è vista costretta dalla vita a un accomodamento più meschino ma anche più realistico. La sua malinconia tuttavia non può essere pensata come il risultato della frustrazione delle sue aspirazioni al mondo del Grand Hotel. Piuttosto consiste (e in questo essa è la stessa che sta dietro a tutto il film come la malinconia propria di Fellini) nella fine della possibilità di sperare, di fantasticare sul futuro. Il futuro del cinema felliniano è sempre il sogno della mitica e antistorica riconquista della purezza e della fuga dalla mediocrità. Si è visto come dopo tutto non sia altro che il bisogno di ricostituire il passato. Ora invece finisce, per Gradisca e per Fellini, la possibilità di pensare che da qualche parte, in un assoluto oltre, ci sia ancora futuro, ci sia ancora speranza. Marcello in La dolce vita non era stato capace di raggiungere questo oltre, tuttavia esso tornava come possibilità nei film seguenti. II matrimonio di Gradisca è la fine di tutto questo. Il passato è passato ormai solo come tale, privato totalmente del futuro. Per il decadente (ma artista) Fellini, quando il passato non è più capace di dare senso al futuro, questo appunto non ha più alcun senso. Dopo tutto la morte di cui parlava il vecchio è proprio questo: è il nulla che resta come unica prospettiva.
Roberto Escobar, Cineforum n. 131, 4/1974 |
|
| Critica (2): | Conforto o strazio, la memoria ci possiede. In attesa di scoprire l'arte di dimenticare, il segreto del vivere felice sta nel saper governare questa visitatrice implacabile. In Amarcord, che in romagnolo vuol dire appunto "Mi ricordo", Federico Fellini mostra
di saper sfuggire al ricatto della nostalgia e di mettere a frutto i fantasmi del passato. Innestando nella sua vena visionaria una consapevolezza sociologica che dai tempi della Dolce vita sembrava smarrita, Fellini ci dà
un capo d'opera che è insieme un magico, doloroso itinerario fra gli orti dell'adolescenza e un giudizio lucidissimo, nonostante la lente grottesca, delle vergogne che abbiamo alle spalle, delle radici meschine di cui ancor oggi si nutre la realtà dell'Italia, e la fanno goffo melodramma, tragedia buffa, ribalta di infantilismi. Luogo canonico della recita è il Borgo, una cittadina inventata (con Rimini in filigrana) che riassume i connotati di quella provincia italiana, paese dell'anima e culla di illusioni, in cui i molti vizi e le poche virtù del bel paese, tarlato dall'educazione cattolica e disponibile ad ogni fascismo, si compongono in un'immagine tanto più comica del mondo quanto più il vivere è gretto e violento, e repressa la libertà. Siamo negli anni Trenta, e tutto quello che accade nel Borgo ha i segni dell'ira, della follia, dell'assurdo. Il filtro della memoria li colloca nel mito, ma non li assolve: all'apparenza sgangherati e addolciti nel dormiveglia della ragione, racchiudono i rimorsi e le paure di chi oggi, cercando di rientrare col sogno nel ventre materno, lo riconosce infetto, nero involucro di abiezioni, ridicolaggini e ignoranza. Protagonista è un burattino che come Pinocchio vuol divenire uomo: l'adolescente Titta, figlio di un padre iracondo che da capomastro s'è fatto impresario, e d'una madre isterica e lamentosa. Intorno a lui, la bella famiglia italiana: il nonno citrullo, lo zio lazzarone, la florida serva, il fratellino gianburrasca. E intorno alla famiglia, i mostri del Borgo: Gradisca la bellona con le sue vallette, Volpina la gatta infoiata, l'avvocato zuppo di retorica preso a pernacchie quando vanta le origini antiche del Borgo, la fauna dei professori di liceo... E ancora un prete balordo, una tabaccaia immensa di poppe, i gerarchi che vanno di corsa, una stranita famiglia patrizia, il matto Giudizio, Biscein il gran bugiardo, un principe sceso dalla luna, un padrone di cinema che s'atteggia a Ronald Colman, Colonia che annaspa nel pozzo nero in cerca d'un anello... E il coro, finalmente: gli insolenti compagni di Titta, ciccioni e allampanati, masturbati nella mente e nel sesso da fantasie micidiali, e il popolo affamato di novità, la borghesia cretina, i torvi fascisti, un motociclista imbecille che passa e ripassa rombando. Così fu l'Italia, grande elemosiniera di speranze, così è l'Italia dei santi e degli eroi. Costruito su una struttura rapsodica, che intreccia episodi e figure col filo dello stupore, Amarcord è l'opera di un Fellini adulto e civile, in cui l'autobiografismo, come già in Otto e mezzo (ma il film rimanda anche ai Clowns), è maturato in chiave di conoscenza storica e in dramma generazionale. Con questo di impagabile: che un lievito di ferocia ha preso il posto del piangersi addosso, e conferisce ai volti, alle cose, ai luoghi una violenza espressiva spesso insostenibile. Passerella di pagliacci, di infami, di sconfitti, sempre di subalterni, Amarcord è il trionfo del tragico raggiunto attraverso la risata, è un uncino nel cuore e una matassa di seta. È un esorcismo liberatorio e un'adunata, nelle grotte della memoria, scossa dai singhiozzi. È lo sgomento di un passato che la retorica proustiana non sublima, e la disperata ricerca di una rigenerazione impossibile compiuta attraverso la smorfia, il sarcasmo, e la meraviglia della morte. Quasi tutto Amarcord è danza macabra su un ilare sfondo e palio dei buffi fra quinte sinistre, con pause di assorto rapimento e amare discese agli inferi dove l'infanzia, quella infanzia, alimenta le nostre nevrosi, la vocazione al patetico e al rissoso. Emozione e fantasia, invenzione d'artista e padronanza assoluta del mestiere si danno la mano in uno spettacolo senza ombra di intellettualismo dove nulla è vero, perché tutto è ricostruito (anche il mare), e tuttavia la realtà, portata al limite del tripudio onirico, ha come non mai peso e spessore, abitata da attrazioni e ripulse, attese e spaventi, che sono il tessuto della vita e il suo controcanto elegiaco. Gli esempi non si contano: dalla concitata festa iniziale delle "fogarazze" che dà l'addio all'inverno all'arrivo al Borgo del nuovo federale emerso dai fumi neri della vaporiera; dalla notte in cui un violino remoto suona l'Internazionale e accende l'ira dei fascisti a quella d'incanto in cui la bella del Borgo si offre al principe reale ("altezza, gradisca..."); dal burlesco arrivo dell'emiro al Grand Hotel al pomeriggio di angoscia in cui lo zio matto s'arrampica su un albero e invoca una donna; dalla fiabesca apparizione notturna del "Rex" sfavillante di luci, prodigio e lacrime per una folla assonnata, all'aggirarsi del nonno nella nebbia e alla paura del bimbo; e ancora dall'eccitante passaggio dei bolidi delle Mille Miglia al languore di quei ragazzi che mimano tra le foglie d'autunno, le danze del belmondo; dalla sconcertante avventuradi Titta con la tabaccaia alla morte della madre e alle nozze di Gradisca col carabiniere, chiuse in una luce di crepuscolo fra brandelli di voci, e la fisarmonica del cieco che strugge il paesaggio... tutto, ecco, tutto affiora e si cancella, portato dal vento del mare e custodito dalle nuvole. In un calcolatissimo impasto di toni gravi e lievi, con svolte improvvise nel beffardo e nel fumetto, così Amarcord cresce e tempera le ombre, le smargina d'ogni scoria verista, e le muove nel grembo della leggenda. Intrecciati ai timbri d'argento, alle risate a piena gola, i rintocchi della malinconia minacciano d'avere il sopravvento. La trappola della memoria è scattata ancora una volta? In realtà siamo feriti, ma salvi. Forse il Pinocchio che è in noi esce dal buio, smette i calzoni alla zuava e brucia con i ricordi il suo mondo piccino. Tutta la sua vita, domani, sarà una lotta contro il Borgo, contro la tentazione di rifugiarsi nel tepore dei miraggi. Aiutato nella sceneggiatura dal conterraneo Tonino Guerra, col quale ha anche firmato un libro in cui, ma da lontano, si respirano i fatti del film, dallo scenografo Danilo Donati, dal fotografo Giuseppe Rotunno, dal musicista Nino Rota, da attori quasi tutti sconosciuti, il cantastorie Federico Fellini ha detto con Amarcord, sull'Italia degli anni fascisti, forse più e meglio di tanti storici di professione. Dobbiamo essere grati al suo talento. Dobbiamo sperare che i nostalgici, confrontandosi col passato, misurino l'abisso di puerilità, di appetiti repressi, di smanie e cafonerie in cui naufragarono, petti in fuori e pancia in dentro. E anche i giovani ne ridano, ne ridano, ne ridano, con un'unghia di pietà per i loro padri indifesi.
G. Grazzini, Gli anni Settanta in cento film, Laterza 1978 |
|
| Critica (3): |  |
|
| Critica (4): |  |
 | |
 |  |
|
 indica che il link è esterno al web comunale
indica che il link è esterno al web comunale
