Grande racket (Il)
|  |  |  |  |  |  |
| Regia: | Castellari Enzo G. |
|
| Cast e credits: | 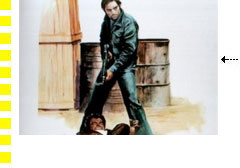
Soggetto: Massimo De Rita, Dino Maturi; sceneggiatura: Enzo G. Castellari, Dino Maiuri, Massimo De Rita; fotografia: Marcello Masciocchi; musiche: Maurizio De Angelis, Guido De Angelis; montaggio: Gianfranco Amicucci; scenografia: Francesco Vanorio; arredamento: Carlo Gentili; costumi: Luciano Sagoni; interpreti: Fabio Testi (Nicola Salmeri), Renzo Palmer (gestore del ristorante), Vincent Gardenia (Zio Pepe), Sal Borgese (maresciallo di polizia), Gianluigi Loffredo (Tony, il marsigliese), Orso Maria Guerrini (il cacciatore), Marcella Michelangeli (la ragazza della gang); produzione: Cinemaster; distribuzione: Cineteca di Bologna; origine: Italia, 1976; durata: 110’. |
|
| Trama: | Il maresciallo Nicola Palmieri della polizia romana è sulle piste di una banda di taglieggiatori: le sue indagini, però, sono ostacolate dalla paura delle vittime e dall'ostilità dei superiori che non approvano i suoi metodi. Deciso a proseguire per la sua strada, il maresciallo s'accorda con due malviventi di mezza tacca, zio Pepe e suo nipote Picchio che in cambio di una certa libertà d'azione gli forniscono informazioni sulla banda. Presente, grazie a Pepe sul luogo di una rapina messa a segno dai banditi, la polizia ingaggia con loro una furiosa sparatoria. In questa occasione è di valido aiuto a Palmieri un campione olimpionico di tiro al piattello, l'ingegnere Gianni Rossetti. Mentre, però, i delinquenti si vendicano sia del Rossetti, bruciandogli viva la moglie, sia di Pepe, facendogli uccidere il nipote, Palmieri viene costretto a lasciare la polizia. Questo, però, non basta a fermarlo: spalleggiato da Rossetti, da zio Pepe e da altre vittime della banda, il maresciallo affronta i delinquenti nella loro tana facendone piazza pulita. |
|
| Critica (1): | Quando nel 1976 Enzo G. Castellari arriva a dirigere questo esemplare solidissimo e pressoché unico di action-noir all’italiana, non è certo nuovo a pellicole di stampo poliziesco dalla scioltezza ritmica vertiginosa, costruite per lo più sull’accumulo di scene rocambolesche affidate in primis alla destrezza degli stuntmen.
Già con La polizia incrimina, la legge assolve, anno di grazia 1973 (lo stesso di La polizia ringrazia), il cineasta romano (figlio di Marino Girolami e nipote di Romolo Guerrieri) aveva contribuito alla nascita del "poliziottesco", codificando con Franco Nero la figura del commissario crepuscolare che combatte la malavita violenta usando le sue stesse armi, al confine della legalità, mentre soltanto l’anno successivo, con Il cittadino si ribella, anticipa tematiche a là Giustiziere della notte, sublimando la plumbea sociologia di quegli anni in cinismo ruvido e senza speranza.
Ma è soltanto, appunto, con Il grande racket – e col film che gli succede, La via della droga – che Castellari firma i suoi veri, autentici, capolavori all’interno del genere (per molti, il suo miglior film resta il western Keoma, girato subito prima), opere auree nella sua pur ricca filmografia, dove il nostro si libera definitivamente della maggior parte dei cascami naturalistici legati al milieu sociale e alle motivazioni psicologiche dei caratteri, arrivando a puntare il tutto per tutto sul meccanismo chiastico di azione e vendetta, motore unico dell’accelerazione iperbolica impressa all’intreccio mano a mano che il film procede nel suo metraggio.
La partenza astratta, con la presentazione unilaterale, epidermica, della banda dei quattro cattivissimi taglieggiatori romani di piazza Navona – alle cui malefatte aderiamo in diretta, grazie all’impiego di macchina a mano in long take – crea da subito un clima di disagio e asperità, scatenando una forma di violenza sbrigativa e apparentemente incontrastabile, che muove dal basso per assaltare la tranquillità piccolo-borghese dei commercianti del rione. La furia dei quattro mastini, descritta di frammento in frammento, sembra non avere cedimenti pietistici. Ne vediamo i risultati, la forza inaudita, senza che sia possibile risalire alla sua origine scatenante, tanto da apparire come un elemento dalla potenza quasi sovrannaturale, tanto ineluttabile quanto inattaccabile.
Legando abilmente, grazie all’uso di ellissi apodittiche, momenti ugualmente carichi di tensione, il montaggio tralascia ogni tipo di sequenza di raccordo la cui funzione sia soltanto quella di aggiungere ulteriori chiarimenti all’evolversi dell’intrigo. Ne deriva un effetto-sorpresa in alcuni momenti davvero spiazzante, allarmante, come quando ad un’azione segue istantanea la propria logica, inappellabile, reazione.
Nulla appare superfluo alla scansione degli eventi: Castellari sfronda ogni retorica da cinema civile, penetrando la dimensione astratta del sadismo, utilizzato come arma dalle squisite, potentissime, qualità cinematografiche, capace di imprimere spessore ed unicità ad icone squadrate e pantografate come i fumetti di Lichtenstein.
Non è un problema, quindi, constatare un alto grado di approssimazione psicologica nella galleria di personaggi piazzati da Castellari nel suo sorprendente meccanismo di cinema; anzi, una tale icasticità possiede invece i tratti della stilizzazione artistica, raddoppiando così la deflagrazione sensoriale e affettiva della pellicola.
Da Fabio Testi, commissario di ferro che passa dalla sconfitta al riscatto, secondo un percorso shakesperiano comune alla narrativa dell’antieroe, a Rudy il Marsigliese, cattivo numèro deux, presentato magistralmente da una serie di jump cut sul primo piano semi-freezer, da star della malavita, che tanto sarebbero piaciuti a Tarantino; da Orso Maria Guerrini, campione di tiro al piattello che si allea alla "sporca dozzina" mosso unicamente dalla sete di vendetta, alla saggezza abilissima, sagacemente popolare, di Vincent Gardenia (l’informatore "buono" Zio Pepe); dalle macchiette romane di Glauco Onorato (boss della malavita meno cattivo di quel che sembra) e Massimo Vanni (il più estroso della "banda dei quattro"), a cui sono affidate tra l’altro le battute più apertamente coatte, da strappapplauso-risata in sala, a Renzo Palmer, ristoratore e padre modello, a cui è riservata la sottotrama tragico-larmoyante con risvolti neurologici; da Sal Borgese, deuteragonista collega di Testi, destinato ovviamente al sommo sacrificio, agli antagonisti superspietati Roberto Dell’Acqua (lo stupratore), Marcella Michelangeli (la femminista) e Romano Puppo (il duro).
Ognuno di loro ha la bidimensionalità necessaria per aderire al quadro di fondo ordito da Castellari; ognuno ha un tratteggio caratteriale immediato ma puntualissimo, tramite cui ottenere una sorta di risarcimento del personaggio, che risale così dallo stereotipo all’archetipo.
A funzionare, dunque, è in primis l’architettura affettiva del plot, concentrata su di un’episodicità lineare, scarna, essenziale, a tutto vantaggio delle sequenze d’impatto, che divorano il testo grazie all’esplosione dei propri contenuti interni, orbitanti intorno all’iperviolenza espressiva e ai possibili risvolti sadici della trama.
È qui, dunque, nella pura dimensione dell’artefatto cinematografico, nella continua invenzione di messa in scena, nello scarto dal naturalismo e dall’imbolsita rappresentazione della realtà, è nel regime, appunto, dell’immaginario, dell’iperreale, dell’attrazione, che il film vive la sua più piena realizzazione, riuscendo ad attecchire maniacalmente fin dentro la pelle dello spettatore.
Come Dario Argento nei suoi primi, formidabili, gialli, Castellari riesce a rendere credibile l’incredibile, verosimile l’inverosimile; riesce a (ri)creare un universo intero a partire dalla rapidità e dalla precisione dei dettagli di superficie, più che dallo scavo in profondità; riesce, soprattutto, a trasfondere tutto ciò nel trionfo della tecnica cinematografica, padroneggiata ampiamente non solo nelle soluzioni visive sempre molto adeguate al gioco della mise en scéne, ma anche nella scorrevolezza fuori dal comune raggiunta dall’estrema funzionalità del montaggio, che stira la tensione fino all’inverosimile.
La stessa tessitura del plot – che è poi quella tipica del noir, o del western suburbano alla di Leo (ma diversamente dal suo collega, Castellari, come già detto, non è interessato tanto all’indagine sull’ambiente, quanto alla concitazione ritmica puramente cinematografica) – non fa che caricare la spinta al riscatto e alla vendetta del protagonista e dei suoi sodali; non fa che acuire il livore verso i personaggi spregiativi, che mostrano inconsapevolmente una crudeltà dai connotati artaudiani, rafforzata dal fatto di giungere inaspettata, e per così dire, gratuita, cioè sganciata da cause razionali drammaticamente motivate, da strategie del realismo, da situazioni da cinema povero d’impegno.
A Castellari basta un pretesto – la malavita piccolo-medio-grande romana, irrelata ad una struttura piramidale che si estende fino agli insospettabili poteri parastatali – per dare verità cinematografica ai suoi antieroi da cultura popolare bassa. La critica sociale, men che secondaria, funziona però con un’efficacia molto più grande e densa di echi rispetto a molti dei magniloquenti primi piani di un Rosi o un Montaldo. Come nei fumetti sadici degli anni ’60 e nelle loro coeve traduzioni cinematografiche (i western italiani più efferati, appunto), la descrizione ambientale e i rapporti con l’attualità storica fanno solo da tramite, da macguffin, per dare sfogo al proprio personale deliro di messa in scena, senza con ciò precludere l’apertura del testo al di fuori di sé, alla condanna tristemente plausibile delle losche orditure di una società civile truffata e abbagliata dallo spettro del potere oligarchico.
D’altronde, col western italiano, il noir-action di Castellari ha in comune più di un elemento; non solo la cornice assimila le lande desertiche dei villaggi di frontiera alla desolazione priva di punti di riferimento tipica della metropoli degli anni di piombo, ma anche i nodi drammaturgici – il percorso diegetico fondato sulla diade azione-reazione, uccisione-vendetta ecc… – e la follia disperata dei personaggi è praticamente la stessa.
Come identica è la mitologia dell’antieroe, disilluso, sacrificato, e quasi sempre sconfitto, che dinnanzi al letargo o all’impotenza delle istituzioni, si costringe a superare i vincoli della legalità per rinsaldare un qualche equilibrio sociale valido. (…)
Pierpaolo De Sanctis, cinemavvenire.it |
|
| Critica (2): |  |
|
| Critica (3): |  |
|
| Critica (4): |  |
 | |
 |  |
|
 indica che il link è esterno al web comunale
indica che il link è esterno al web comunale
