Ultimi fuochi (Gli) - Last Tycoon (The)
|  |  |  |  |  |  |
| Regia: | Kazan Elia |
|
| Cast e credits: | 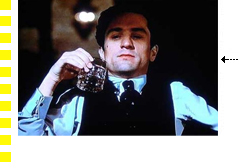
Sceneggiatura: Harold Pinter, dal romanzo omonimo di. Francis Scott Fitzgerald; fotografia: Victor Kemper; scenografia: Gene Càllahan; montaggio: Richard Marks; musica: Maurice Jarre; interpreti: Robert De Niro (Monroe Stahr), Ingrid Boulting (Kathleen Moore), Robert Mitchum (Pat Brady), Tony Curtis (Rodriguez), Jeanne Moreau (Didi), Theresa Russell (Cecilia Brady), Anjelica Huston (Edna), Donald Pleasence (Boxley), Jack Nicholson (Brimmer), Dana Andrews (Red Ridingwood), Ray Milland (Fleishacker), Peter Strauss (Wylie), John Corradine (guida del tour); produzione: Paramount; origine: USA, 1976. |
|
| Trama: | Negli anni Trenta, Monroe Stahr è il brillante e dispotico direttore di una importante casa di produzione hollywoodiana. Durante il trambusto provocato negli studi da una scossa di terremoto, Monroe rimane turbato dalla vista di Kathleen, una ragazza che gli ricorda la moglie, scomparsa prematuramente. Monroe riesce a conquistare la confidenza della ragazza e ne diviene ben presto l'amante. Ma l'avventura sentimentale gli fa trascurare gli amici, il sincero affetto di Cecilia e lo rende negligente sul lavoro. Finirà per essere defenestrato dai suoi stessi collaboratori mentre Kathleen si sposa con un altro. |
|
| Critica (1): | Quando un film è tratto da un’opera letteraria, si è portati a porsi la vecchia, solita domanda: se esso sia rimasto realmente fedele al testo. Una domanda più che legittima, se nasce da un’esigenza di natura filologica o storìografica. Spesso però proviene, più o meno inconsciamente, dal pregiudizio ancora radicato per cui la letteratura gode di un primato sul cinema, arte inferiore incapace se non in casi eccezionali, di approdare ad autonomia dignità artistica.
L’equivoco della rispondenza del film al libro, come se al primo spettasse solo il compito subalterno di tradurre in immagini un pensiero già espresso, si perpatua. «Nonostante lo sforzo, compiuto dal cinema fin dagli esordi per conquistare una propria autonomia espressiva – scrive Gian Piero Brunetta (Letteratura e cinema, Zanichelli Bologna, 1976) – la sua storia è anche la storia di un rapporto continuo ed ininterrotto con le strutture letterarie che lo precedono e lo condizionano».
Non sarà dunque ozioso ripetere ancora che, non esistendo tra i due mezzi espressivi identità di codice (si tratta di serie semantiche differenti) la ricerca di una identità assoluta (nella trama come nello spirito) è priva di senso. Un regista cinematografico (e con lui in parte lo sceneggiatore) dovrebbe essere chiamato a rispondere soltanto dei risultati espressivi inerenti allo specifico/cinema, e non al rapporto con la fonte. Suo compito è infatti di vivificare la materia con la propria personalità e di trasformarla in immagine significante e non di illustrare il testo. Leggerla, insomma, “in un certo modo”. E più farà questo, più si allontanerà dall’opera letteraria, e più sarà un buon regista. [...]
Se si fa qui un breve esame delle differenze tra il romanzo di Fitzgerald ed il film di Kazan (oltre che per una doverosa informazione nei confronti del lettore) è proprio per verificare il grado di autonomia tra le due opere, e per sottolineare il valore del film e l’apporto creativo dei suo autore, il quale tra l’altro, oltre ad essere un regista, è anche un valido romanziere.
The last tycoon è l’ultimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, rimasto incompiuto per la morte dell’autore (stroncato da un attacco cardiaco il 21 dicembre 1940, all’età di 44 anni) e pubblicato postumo, nel 1941.
Nel descrivere la parabola verso il fallimento del produttore cinematografico Monroe Stahr, un altro grande simbolo del “sogno americano” infranto, l’autore di "Tenera è la notte", "Di qua del Paradiso", "Belli e dannati", "Il Grande Gatsby", [...] vi immise tutta l’amarezza della sua personale esperienza che ebbe come sceneggiatore ad Hollywood, prima in due brevi periodi, nel 1927 e nel 1931, e poi dal 1937, sotto contratto per la Metro Goldwyn Mayer, fino alla morte. [...]
Scrittore celebre ed affermato, frequentatore dei salotti mondani ed avvezzo alle adulazioni del pubblico, ad Hollywood Fitzgerald si trova dunque a dover svolgere un lavoro anonimo e di gruppo, soggetto agli ordini e agli umori di potenti produttori, sensibili solo alle leggi dei denaro, costretto a piegare le proprie esigenze narrative a quelle commerciali del “system” hollywoodiano. I suoi copioni non convincono, gli vengono imposti continui tagli e modificazioni, per poi sostituirlo con qualche oscuro sceneggiatore più dotato di “mestiere” e di malleabilità.
[...] In The last tycoon Scott Fitzgerald proietta dunque questa sua infelice esperienza nel personaggio di Monroe Stahr, nel quale non è difficile identificare Irving G. Thalberg, il famoso produttore della MGM, [...] entrato nella storia del cinema per essere stato il nemico dichiarato di un grandissimo e sfortunato regìsta, Erich Von Stroheim. [...].
In Monroe Scottr Fitzgerald non rappresenta soltanto Thalberg ma anche se stesso: l’improvvisa infatuazione di Stahr per Kathleeen Moore, la giovane donna che gli ricorda la moglie morta [...] è un’allusione all’innamoramento di Fitzgerald per Sheila Graham, con la quale lo scrittore visse dopo la morte della moglie Zelda Sayre.
[...]
La trasposizione del. romanzo sullo schermo, tanto per non smentire i difficili rapporti di Fitzgerald con il cinema, sembra partire male: in un’intervista rilasciata a Michel Ciment Elia Kazan confessa infatti di non avere avuto intenzione di girare questo film, ma che gli era stato offerto dal produttore Sam Spiegel, dopo il. rifiuto a dirigerlo da parte di Mike Nichols (Il laureato, Comma 22, Conoscenza carnale).
Per stendere il copione, poi, era stato chiamato lo scrittore Harold Pinter (lo sceneggiatore abituale di Joseph Losey), un temperamento molto diverso da quello di Kazan.
Le premesse non sono state dunque le migliori, anche perché Kazan aveva accettato alla fine soltanto con lo spirito di prendersi “una vacanza”.
Perché allora ne è risultato un ottimo film? La risposta è data dall’interrogativo posto in partenza: il film è riuscito perchè Kazan, utilizzando al meglio il romanzo di Fitzgerald ed il contributo di Pinter, ha saputo ricondurre entrambi alle proprie tematiche ed alla propria personalità di autore cinematografico.
Ciò che conta e ciò che vale nel The last tycoon cinematografico non è la fedeltà al testo (tra le differenze più vistose l’abbandono della tecnica della narrazione in prima persona da parte di Cecilia, ed il finale inventato senza neppure tener conto delle indicazioni lasciate dall’autore il quale intendeva far morire Stahr in un incidente aereo) ma la fedeltà a se, stesso perseguita con accanimento e rigore. Andando oltre Fitzgerald senza mai dimenticarlo nè tradirlo (e così il suo film diventa anche il primo vero film sull’opera dello scrittore) Kazan ha realizzato, ispirandosi all’opera più matura di Fitzgerald, la sua opera più matura, fondamentale non solo nella sua filmografia almeno quanto Il compromesso o Il ribelle dell’Anatolia ma nell’intero panorama dell’ultimo cinema americano.
La vicenda di Monroe Stahr emblematizza, nella lettura di Kazan, il cinema americano nei suoi più tipici aspetti: il mito, l’industria, la finzione, la vita.
Il film inizia con una sequenza che ricorda ironicamente Casablanca, il film del mito per eccellenza, con due attori (Jeanne Moreau e Tony Curtis) che amabilmente contribuiscono a distruggere, con quello dell’attore, il loro stesso mito: la bellezza della Moreau costretta a fare i conti con una macchina da presa impietosa che scava tra le rughe dei suo viso e ne riprende le meschine isterie sul set; la virilità di Curtis messa a dura prova dal ruolo stesso dei personaggio di Rodriguez, casanova sullo schermo e impotente nella vita. Nella visita dei turisti agli “studios” un altro mito del cinema hollywoodiano, John Carradine, indimenticato eroe di Ombre rosse, fa da accompagnatore nei camerini degli attori, dove si prolunga, attraverso la conservazione degli arredi, una vita fasulla oltre la morte. Minna Davis, applaudita e famosa attrice moglie del produttore cinematografico Monroe Stahr è morta da poco, ma il suo camerino sembra pronto ad attenderla da un momento all’altro, secondo un macabro desiderio di sfida alla morte, tipicamente americano, così ben descritto nel film di Tony Richardson Il caro estinto, e che trova nel cinema, in quanto illusione di vita, la sua più perfetta espressione. Se Francois Truffaut, nel suo film sul cinema, Effetto notte, aveva voluto affermare che il cinema è un’altra realtà, con leggi e logiche sue proprie, e che la finzione cinematografica può essere un’altra forma di vita, Kazan mostra ne Gli ultimi fuochi, di non credere a questa illusione, pur desiderandolo intensamente. È vero, attraverso il cinema si sfida la morte perchè ciò che è stato impressionato resiste al di là delle vicende umane, ma i grandi attori del cinema americano, qui ritrovati come grottesche maschere di un presente in disfacimento (da Dana Andrews a Robert Mitchum a Ray Milland) non costituiscono il più feroce richiamo alla amara verità della decadenza e della morte?
È solo nel desiderio dunque che Kazan ritrova l’identità tra cinema e vita, dando al personaggio di Stahr la duplice connotazione di creatore e di consumatore di miti cinematografici, rendendolo simbolo vivente del “doppio” (così come un doppio è Kathleen) che costituisce, nella sua relazione con la vita reale e nella sua autonomia rappresentativa, l’anima del cinema. E questa relazione, come si vedrà più avanti, la si troverà espressa nell’episodio-chiave del nichelino, in cui la rappresentazione inventata da Monroe Stahr ad uso esclusivo del cinema, diventerà invece la visione del suo stesso dramma privato. Il rapporto tra realtà e finzione lo si rinviene anche nella dimensione del fenomeno naturale, oltre che nell’ambito dei sentimenti: si parla del terremoto come trucco, e poi questo, dopo solo qualche minuto, avviene realmente, coinvolgendo cinema e vita in un’unica, tragica situazione. In mezzo a questa grande fabbrica dell’immaginario collettivo che è il cinema americano, con i suoi sogni indotti e la sua più mediocre realtà, tra loro in un rapporto complesso ed inestricabile di reciproche cause ed effetti, si taglia l’immagine potente del “tycoon”, del magnate, del produttore demiurgo, vero “deus ex machina” dell’apparato cinematografico, colui che ha il potere di rovinare con un gesto attori e registi; che può licenziare in tronco sceneggiatori che hanno alzato troppo il gomito o che non riescono a tradurre in produzione letteraria quanto egli richiede da loro, ritenendoli semplici “braccianti” della penna ai quali (come emerge dal dialogo tra Stahr e il sindacalista) si potranno dare “più soldi ma non più potere”; che possiede il diritto all’approvazione di ogni opera, dal copione fino al “final cut” (il montaggio definitivo); che imposta la “linea” della casa di produzione secondo precisi parametri ben identificabili al di là dei singoli film realizzati e dell’apporto creativo dei diversi registi che è progressista nelle idee sul cinema (ama il cinema di qualità) e conservatore negli atteggiamenti politici (teme i “rossi”), e di lavoro. È l’industria hollywoodiana, struttura particolare e differente da, ogni altra industria cinematografica, guidata dai criteri del massimo profitto, dell’alta professionalità di tutte le componenti; artistiche e tecniche e deil’esportabilità sul mercato internazionale, conscia del proprio ruolo, anche sociopolitico, oltre che economico, di organizzazione del consenso.
Questo ambiente, egregiamente tratteggiato da Kazan attraverso sottili indicazioni e penetranti rimandi che intendono ricostruire più che denunciare, senza ombra di nostalgia nè di acre polemica, trova la sua più appassionata rappresentazione nella figura di Stahr, il quale racchiude in se, ultimo erede di una tradizione autoritaria di stampo paternalistico illuminato (nei suo sentirsi padre, amico e nemico insieme delle creature filmiche che contribuisce in misura così determinante a far nascere, e con quella invadenza e quel tono pedagogico di chi mette altro nel proprio lavoro, oltre al capitale), il bene e il male del cinema americano.
Stahr è infatti l’ultimo produttore che sa unire talento a fiuto industriale, capacità manageriali a doti di conoscenza del pubblico, è colui che ama rischiare se crede nel prodotto, convinto di poter dare qualcosa di positivo agli spettatori («milioni di persone vanno al cinema, i film sono necessari, danno quello di cui esse hanno bisogno») e di avere anche dei doveri verso di loro, al contrario della classe imprenditoriale destinata a succedergli, più anonima e cinica, tesa sol tanto al recupero del profitto preventivato. È Nex York, il centro del capitale finanziario, che vince contro Hollywood, la piccola cittadina del “sogno” cinematografico. Monroe Stahr, in altre parole, è più disarmato ed ingenuo, come ill paleocapitalista che conserva, nei confronti del neocapitalista, la sua umanità. Convinto che il successo lo si possa conquistare e mantenere secondo i principi dei “padri” («che cos’eri tu? un fattorino, e io un garzone di drogheria questa è l’America») partecipa emotivamente egli stesso ai miti che crea, secondo una dinamica interna sconosciuta alle figure degli altri soci, come quella di Brady, il padre di Cecilia, destinato a succedergli nella direzione dell’azienda. Nella struttura cinematografica di cui è capo, e nella quale sono portati a razionalità imprenditoriale le irrazionalità dell’allucinazione filmica, entra improvvisamente l’irrazionale concreto, il dato imprevedibile che viene ad incrinare tutto l’apparato: Monroe Stahr, il produttore ricco e affascinante, corteggiato dalle donne, tra cui Cecilia, pronta a darsi a lui, si innamora di un’apparizione magica, di un’idea, di una concezione della bellezza e dell’amore che appartiene al sogno e alla irraggiungibilità del desiderio. In Kathleen, che in realtà ricerca solo la sicurezza e la tranquillità sociale attraverso un matrimonio convenzionale («io voglio una vita tranquilla») Stahr vede invece, nel suo folle innamoramento di un miraggio, una entità misteriosa paragonabile a una naiade acquatica, inavvicinabile e indecifrabile, bella come una ninfa marina o una sirena di cui si può riuscire soltanto a gustare il dolce canto. Creatura bianca e pura, Kathleen è ripresa o mentre sorge simbolicamente dall’acqua (come nell’apparizione sulla testa di cartapesta di sapore felliniano) o dietro fontane e cascate: fresca e luminosa come una visione botticelliana, essa è sogno e mito miraggio e desiderio, che si pone in rapporto a Minna, come il cinema nei confronti della vita.
È stato detto che la relazione sentimentale tra Stahr e Kathleen occupa uno spazio, eccessivo nel film. In vece questa relazione non è una storia d’amore che irrompe nel “discorso” sul cinema americano e sulle sue strutture, ma è anch’essa parte integrante di questo discorso. Così, la lunga scena d’amore sui bordi di quella villa in costruzione, ancora senza tetto, in riva al mare, che simboleggia, nella sua incompiutezza, la natura del suo costruttore, per il tono di eterea autenticità che nasce dall’ambiguità del desiderio finalmente appagato, del sogno conquistato per un attimo alla realtà, oltre ad essere una delle più intese sequenze d’amore della storia del cinema, è una geniale rappresentazione poetica sulle componenti dei fenomeno cinematografico (lo spettacolo, il godimento, l’illussione, il riflesso, il raddoppiamento, lo sguardo). Soprattutto, senza, alcun sovraccarico lirico ma con la trasparenza della, verità poetica, in essa si affida all’atto d’amore la definizione della relazione tra cinema e vita.
Il film di Kazan si fonda su un’altra sequenza-chiave, ripresa dal romanzo di Fitzgerald ma poi deputata a trasmettere tutto il senso del film: la scena del nichelino.
[...] così descritta, nel citato libro di Alfredo Rossi:
Uno sceneggiatore, che ha ambizioni d’autore, fissa un appuntamento con Stahr. Nell’ufficio siedono altri due sceneggiatori “di fiducia” del produttore. Costui si lamenta del fatto che a lui, scrittore di professione, sono stati affiancati due mestieranti. Vanta quindi la bontà comica di una sua scena. Monroe lo interrompe e gli domanda se nei suoi libri metterebbe mai cose del genere. Certo che no – risponde il cinema non è una cosa da prendere sul serio. Monroee lo invita allora a seguirlo con attenzione: gli propone, mimandola, una situazione. Un uomo, stanco per una giornata di stressantelavoro per poter affermare le proprie idee, sedutosi sulla scrivania poggia la testa sul tavolo e si assopisce; ma la porta della stanza si apre improvvisamente e penetra silenziosa e furtiva una donna che non si avvede della presenza dell’uomo. Si avvicina ad un tavolo, posa una borsetta, ne rovescia il contenuto: ci sono un paio di guanti neri, dei fiammiferi e un nichelino. Si avvicina alla stufa, accende un fiammifero e dà fuoco ai guanti che getta nella stufa, ma trattiene il nichelino. Tutto questo avviene sotto lo sguardo dell’uomo, ridestatosi, il quale crede di guardare non visto. A un dato momento si accorge di un altro sguardo domina l’intera situazione: c’è una terza persona che vede il tutto. A questo punto Stahr interrompe la sua messinscena, sorride ai suoi due sceneggiatori e torna a sedersi sulla poltrona. Lo scrittore che ha seguito con crescente curiosità, dopo un attimo, di esistazione, domanda: «E poi che succede?». Monroe, sorridendo, risponde: «Non lo so, stavo facendo del cinema». «E il nichelino?». Uno degli sceneggiatori risponde: «Serve a fare del cinema»: Allora lo scrittore, credendosi preso in giro, si impenna e dice che non capisce niente di tutta questa storia. Stahr risponde che se ha chiesto del nichelino vuoi dire che la capisce; fa il gesto di lanciarglielo, l’altro quello di prenderlo al volo, ma lo trattiene nelle sue mani.
Con questa descrizione così emblematica sul cinema, Kazàn riflette sulle fondamentali caratteristiche del mezzo: la ripetizione, lo sguardo, la relazione cinema/vita.
Il cinema è un bene che può essere riutilizzato all’infinito, come si notava all’inizio dell’articolo, anche oltre la morte dei suoi partecipanti. Ciò che vive sullo schermo, una volta accettata la convenzione, è tecnicamente riproducibile e quindi può diventare da finzione realtà. Ma ad ogni ripetizione (è questo uno dei significati della sequenza, che nel film ritorna significativamente per due volte, e in modo diverso) l’opera non rimane se stessa, bensì acquista valenze differenti, in base al cambiamento del pubblico e al divenire della storia. La scena descritta è vista da un soggetto, il quale, a sua volta, è osservato da un terzo personaggio il quale vede il tutto: il discorso sul cinema e sul suo potere di decifrazione e di mistificazione non potrebbe essere più chiaro. Dalla relatività dello sguardo, si passa all’oggettività di una visione che dovrebbe ricomprendere ogni soggetto, e quindi ogni relatività, ma ciò che sembra essere oggettivo in effetti è soltanto la fantasia descrittiva di Stahr. Tutto torna ad essere relativo, e ciò che sullo schermo diventa immagine visibile, altro non è che immaginazione, non certo verità assoluta e preesistente alla riproduzione visiva. La ripetizione della scena fa scoprire poi che il personaggio femminile è Kathleen, ed il terzo uomo che guarda è il marito: per Monroe Stahr il cinema è diventato così la vita, e la sua vicenda privata si sovrappone alla rappresentazione cinematografica. In una vertigine in cui si disperdono le gerarchie del reale e del fittizio. Ciò che egli aveva prima narrato per mortificae uno sceneggiatore sì rivela essere un aspetto doloroso della propria esistenza, così che anche il racconto in apparenza più gratuito nasconde un’esperienza di vita. E il nichelino, oggetto secondario del racconto indica, nella sua metafora (la moneta rimane sempre nelle mani del produttore) non soltanto l’ambito economico che permette la realizzazione cinematografica, ma, più approfonditamente, che ogni elemento del discorso iconico, anche quello in apparenza più insignificante (è questa, in fondo, la, lezione del grande maestro Alfred Hitchcock) attiene ad una realtà altra, il cinema, in cui esso può diventare elemento determinante.
Una realtà altra che è ambigua e polisensa, e che torna ad essere prepotentemente riaffermata nel bellissimo finale, quando Monroe, lasciato il suo ufficio, scompare dentro quell’immenso studio buio dicendo “non voglio rinunciare a te”. Inutile chiedersi se qua “te” sia riferito alla donna o al cinema: appartiene invece ad entrambi, o meglio, a quella realtà altra che è il desiderio e che in Monroe, grande figura votata al suicidio ha assunto l’aspetto dell’appagamento momentaneo (Kathleen) e dell’inappagamento continuo (il cinema).
Il “non voler rinunciare” non significa allora soltanto un ultimo moto di ribellione nei confronti del proprio fallimento, ma una cosciente indicazione, valida per ogni uomo, che l’esistenza è nel desiderio e nell’immaginario, in uno spazio buio che si può rigenerare continuamente con la luce della propria fantasia liberatoria. Proprio come la vita, che rinasce ogni volta in forme nuove, ed il cinema, che dal buio che ne costituisce già una prima fondamentale atmosfera, sa trarre nuove immagini e nuove evocazioni, nuovi effetti e nuove allucinazioni.
(Vittorio Giacci, Cineforum n.170, dicembre 1977) |
|
| Critica (2): |  |
|
| Critica (3): |  |
|
| Critica (4): |  |
 | |
 |  |
|
 indica che il link è esterno al web comunale
indica che il link è esterno al web comunale
